*Giornalista scientifico e scrittore
*Già direttore del master in Comunicazione scientifica della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste
*Caporedattore del magazine online Il Bo Live, di proprietà dell’Università degli Studi di Padova.
 Da un’esperienza più che trentennale di giornalismo e di comunicazione scientifica (ricordo anche l’importante lavoro che ha svolto al Ministero dell’Università e della Ricerca) come giudica la costante avversione e sospetto che la scienza suscita in Italia?
Da un’esperienza più che trentennale di giornalismo e di comunicazione scientifica (ricordo anche l’importante lavoro che ha svolto al Ministero dell’Università e della Ricerca) come giudica la costante avversione e sospetto che la scienza suscita in Italia?
Da questa mia lunga esperienza nel giornalismo e nella comunicazione della scienza ho rilevato che c’è davvero una reale avversione e un sospetto costanti provenienti da una parte della società italiana.
Molti sostengono che questo atteggiamento nei confronti della scienza sia un residuo della cultura crociana; Benedetto Croce non riconosceva il valore culturale della scienza e da questo deriverebbe l’attuale disvalore della cultura scientifica che tutti noi oggi respiriamo. In realtà questo approccio crociano alla scienza è rimasto egemone in alcune parti importanti della società italiana, ma sono convinto che la causa reale abbia origini un po’ più materiali.
I paesi che sono entrati, o che cercano di entrare, a vele spiegate nell’economia della conoscenza, hanno fondato tutto il loro sistema produttivo su una costante innovazione dipendente dalla ricerca scientifica e tecnologica (che come sappiamo dipende dalla produzione di nuove conoscenze scientifiche). In Italia, tutto questo processo economico non è avvenuto, e oggi ne paghiamo le conseguenze perché di fronte alla nuova globalizzazione il nostro paese ha mostrato tutta la sua arretratezza, e da qui, le nostre difficoltà economiche.
La scarsa cultura scientifica quindi ha determinato una specializzazione produttiva del sistema paese che ha tralasciato la ricerca, e quindi la scienza, e ciò ha comportato uno scollamento sempre maggiore tra il nostro sistema produttivo e il valore della cultura scientifica non solo sociale, ma soprattutto economico.
La scienza ha bisogno di cultura scientifica e questa esiste quando un paese mette in atto tutti gli sforzi possibili per costruire una società democratica della conoscenza. Qual è stato l’effettivo impegno della politica italiana a riguardo?
La politica in Italia non ha fatto molto: né i partiti di centrodestra né quelli di centrosinistra. Purtroppo la sottostima del valore culturale, sociale ed economico della scienza appartiene un po’ a tutto il panorama politico del nostro paese.
Ovviamente esiste, anche in Italia, una parte non banale di politici che hanno avuto attenzione per la scienza, ma è sempre stata una parte minoritaria e purtroppo poco incisiva.
Questo ci riporta alla causa cui ho accennato prima, e cioè la causa della scarsa attenzione della nostra classe politica verso la scienza è stata determinata dalla specializzazione produttiva del sistema paese fondata su un “modello di sviluppo senza ricerca” e quindi senza il protagonismo della scienza.
In Germania, per esempio, questo non sarebbe possibile. Se in Germania i politici fossero disattenti di fronte alla cultura scientifica, l’intero sistema produttivo tedesco imporrebbe loro di prestare molta più attenzione alla scienza e alla ricerca scientifica. Non è un caso che tutta la politica in Germania abbia una forte attenzione verso la scienza, lo si vede anche nel programma di un partito di centro come il partito socialdemocratico, e adesso anche in quello dei verdi che dimostrano un’attenzione alla ricerca scientifica molto importante
La globalizzazione ha come principale referente il libero mercato e una parte importante dell’economia si basa sulla conoscenza scientifica, quindi con la cultura non solo si mangia, ma si cresce. Da cosa dipende, quindi, l’impermeabilità italiana nell’applicazione del diritto alla conoscenza?
Ancora una volta credo che questo dipenda dal modello di sviluppo economico e produttivo del nostro paese. Il diritto alla conoscenza non viene percepito come un valore sociale ed economico. Abbiamo scelto uno sviluppo che non prevede la ricerca scientifica. E queste sono le conseguenze.
Da qui l’impermeabilità italiana al diritto alla conoscenza che rappresenta il risultato di una scarsa attenzione economica, quindi culturale e sociale alla conoscenza scientifica, in particolare, ma anche verso conoscenza in generale. Peraltro, non è che la cultura umanistica di stampo crociano si imponga sulla cultura scientifica; quello che stiamo vivendo è una scarsa attenzione verso l’intera cultura, e questo il paese lo sta pagando a caro prezzo
Noi sappiamo che la biodiversità è uno dei motori dell’evoluzione e in questo momento, in molte società, la biodiversità è anche un valore. E così logica vorrebbe che la biologia della conservazione (branca della biologia che studia scientificamente i fenomeni che influiscono sulla perdita, sul mantenimento e sul ripristino della biodiversità) diventasse la base di scelte gestionali, ma questo, molto spesso, non accade. Forse perché, di là da una risposta empatica molto forte, si ha un’idea molto scarsa su cosa sia veramente la biodiversità?
Credo che questo sia l’effetto della scarsa cultura in generale, e della cultura scientifica in particolare, che si riflette in una insufficiente comprensione di sistemi biologici complessi quali la biodiversità, del significato stesso del termine biodiversità, e del modo in cui si può e si deve salvaguardare la biodiversità.
Da qui derivano i nostri rapporti con il resto del mondo vivente e dell’ambiente in generale che sono formati più dalla ideologia che non dalla comprensione profonda di cosa siano e di cosa significhino.
Negli ultimi 10-15 anni la divulgazione scientifica italiana è cresciuta, ma la biologia della conservazione continua ad essere sconosciuta anche a molti giornalisti scientifici. La biodiversità quindi cenerentola della divulgazione scientifica?
Penso che negli ultimi dieci o quindici anni la comunicazione della scienza, più che la divulgazione scientifica, sia aumentata in termini sia quantitativi che qualitativi in molti settori. Le trasmissioni di Piero Angela raggiungono alti audience e, in Italia c’è un gran numero di Festival della Scienza come in nessun altro paese europeo e forse al mondo.
Non è un caso neppure che ci siano tanti i luoghi di formazione di comunicatore scientifico come la Sissa di Trieste, ma anche Milano, Ferrara, Roma, Bari, Torino e Padova sono diventati luoghi importanti di formazione.
Devo dire che ci sono ormai alcune centinaia, se non qualche migliaio, di persone che in questi 10-15 anni si sono formati e sono diventati ottimi comunicatori scientifici, alcuni sono di eccezionale bravura e non hanno nulla da invidiare ai nostri colleghi di altri di altri paesi.
Se c’è una mancanza di attenzione per la biologia della conservazione è perché anche noi giornalisti viviamo in un ambiente nel quale l’analisi razionale dei fenomeni lascia il passo molto spesso alla ideologia e quindi, molto spesso, anche i media si lasciano prendere facilmente dalla ideologia e dalla emotività piuttosto che dalla razionalità.
Penso però che la razionalità non debba essere disgiunta della emotività; posso e debbo tentare di conservare la biodiversità nel nostro paese e nel mondo agendo sia razionalmente che emotivamente, ma l’emozione non deve mai prevalere e soppiantare la ragione, quindi la nostra azione non deve essere mai ideologica, ma sempre attenta al contesto.
Dobbiamo sempre fare un’analisi del contesto, questo ce lo insegna proprio la scienza; non esistono valori assoluti o decisioni assolute, ma esistono valori e decisioni che vanno prese tenendo conto del contesto. Questo è il significato della cultura scientifica, e quando continuerà ad affermarsi e a diventare prevalente anche nei media, allora anche la cultura della biodiversità diventerà importante.
Grazie Pietro

 I recenti risultati delle elezioni europee ci hanno descritto una vera e propria “ondata verde” in quasi tutto il continente a parte l’Italia dove, in assoluta controtendenza, Europa Verde riesce ad ottenere un consenso del 2.4%. L’Europa della solidarietà e un impegno concreto contro la crisi climatica sono stati metabolizzati da molti europei, ma non dagli italiani. Se e cosa non ha funzionato?
I recenti risultati delle elezioni europee ci hanno descritto una vera e propria “ondata verde” in quasi tutto il continente a parte l’Italia dove, in assoluta controtendenza, Europa Verde riesce ad ottenere un consenso del 2.4%. L’Europa della solidarietà e un impegno concreto contro la crisi climatica sono stati metabolizzati da molti europei, ma non dagli italiani. Se e cosa non ha funzionato?

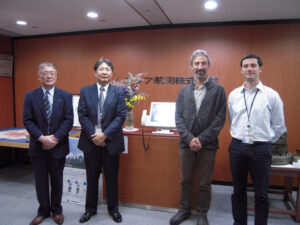 Penso di non andare molto lontano se provo a immaginare la tua mappa mentale come una rappresentazione del pensiero in cui ci sono due componenti principali: una solita e rigorosa base naturalistica e un altrettanto rilevante componente informatica. Quali delle due sono state determinanti, se lo sono state, per la gestione dei conflitti che hai incontrato fino ad ora nel tuo lavoro?
Penso di non andare molto lontano se provo a immaginare la tua mappa mentale come una rappresentazione del pensiero in cui ci sono due componenti principali: una solita e rigorosa base naturalistica e un altrettanto rilevante componente informatica. Quali delle due sono state determinanti, se lo sono state, per la gestione dei conflitti che hai incontrato fino ad ora nel tuo lavoro?
 “Cane sbranato dai lupi!”, così hanno titolato molti giornali negli ultimi anni, dando eco a una diffusa preoccupazione dei proprietari di cani che vivono in zone recentemente ricolonizzate dal lupo.
“Cane sbranato dai lupi!”, così hanno titolato molti giornali negli ultimi anni, dando eco a una diffusa preoccupazione dei proprietari di cani che vivono in zone recentemente ricolonizzate dal lupo.
 Mai come oggi parole come DNA, cromosoma, codice genetico e genomica fanno parte del vocabolario dei media. Dalla TV alla rete, passando per i social, dall’esercizio nella risoluzione spettacolarizzata dei diversi delitti alla determinazione del nostro carattere, dalla filosofia dell’epigenetica passando per la medicina fino alla gestione delle altre specie che con la nostra convivono, sembra ci sia un argomento che più di tutti sbaraglia dubbi e dà certezze granitiche al presentatore della teoria di turno: la genetica. Questo nostro risulta essere quindi un periodo estremamente fecondo per i genetisti, ma è proprio così?
Mai come oggi parole come DNA, cromosoma, codice genetico e genomica fanno parte del vocabolario dei media. Dalla TV alla rete, passando per i social, dall’esercizio nella risoluzione spettacolarizzata dei diversi delitti alla determinazione del nostro carattere, dalla filosofia dell’epigenetica passando per la medicina fino alla gestione delle altre specie che con la nostra convivono, sembra ci sia un argomento che più di tutti sbaraglia dubbi e dà certezze granitiche al presentatore della teoria di turno: la genetica. Questo nostro risulta essere quindi un periodo estremamente fecondo per i genetisti, ma è proprio così?