di Marina BIZZOTTO
Maggiore Carabinieri Forestali
Addetta presso il Coespu alla Cattedra di Polizia per la Tutela Ambientale, Forestale e Agroalimentare

(…) ll crollo delle strutture e gli incendi successivi crearono un’enorme nuvola di polvere e tossine nell’aria sopra la città. La polvere tossica venne inalata dagli abitanti e dai soccorritori finché, tre giorni dopo il tristemente famoso attacco alle Torri Gemelle, Manhattan fu interessata da un forte acquazzone che ne allontanò la parte più consistente della polvere e rese respirabile l’aria.
Punto.
Normalmente a questo tipo di approfondimento del problema si sono mediamente soffermate le notizie e gli infiniti servizi giornalistici sul catastrofico evento. Vero è che il problema ambientale sembrava risibile in confronto alla ricaduta sociale dell’attacco terroristico ma purtroppo non è così.
Arrivò la pioggia si scrisse, in maniera quasi semplicistica… quasi a dire implicitamente l’aria divenne respirabile.
E?
Dove finirono le migliaia di tonnellate di polvere costituita da cemento, materiali da costruzione, metalli pesanti e resti umani?
La pioggia che pulì l’aria divenne un vettore pericoloso che inquinò il terreno e la falda acquifera. In maniera silenziosa l’attacco continuava a mietere vittime, soprattutto tra gli abitanti di Manhattan, senza che il sistema di sicurezza pubblica fosse in grado di mitigarne gli effetti devastanti di amianto, metalli pesanti, fibre di vetro, mercurio, diossina, furano e altri agenti cancerogeni, piombo, benzene nell’acqua e nel suolo.
A distanza di qualche mese venne approvato uno specifico documento per la tutela e la salvaguardia dal bioterrorismo che permise alle città più grandi e alle amministrazioni dei diversi Stati di approntare piani per la tutela e la salvaguardia delle acque. Ma del terreno non parla nessuno.
E cosa ne è stato degli animali e delle piante che sono stati investiti da questa valanga tossica?
Terrorismo ed ambiente: abbinata pericolosa.
Pericolosissima.
L’ambiente che diventa mezzo per creare danno ed insicurezza alla comunità
L’ambiente che diventa strumento di una minaccia asimmetrica.
L’ambiente che diventa finanziatore inconsapevole di guerre del terrore.
L’ambiente degradato quale premessa per radicalizzare idee terroristiche e creare proseliti del terrore tra le persone che patiscono gli effetti di una natura sconvolta da disegni diabolici e vedono l’organizzazione terroristica come valida alternativa, o più drammaticamente unica, alternativa, alla morte.
E in tutti questi casi l’ambiente è la vittima: che non ha voce per lamentarsi.
Da queste riflessioni deriva una ricerca basata su dati oggettivi e su situazioni reali che, purtroppo, sono molte e con esiti più o meno drammatici.
Quali proporzioni ha raggiunto il danno ambientale creato dai pozzi di petroli incendiati durante la Guerra del Golfo?
Quale danno sta perpetrando Daesh all’agricoltura del nord iracheno?
Cosa accade nei campi di addestramento delle milizie di Al-Qaeda dove i campionamenti del suolo, eseguiti dopo lo smantellamento, hanno permesso di rilevare tracce di agente nervino e altre sostanze letali?
E quale scopo avevano le armi chimiche, nucleari e biologiche di cui è stata trovata traccia in alcune zone remote in Afghanistan dove si addestrano i terroristi?
Queste non sono semplici domande ma spunti per riflettere sugli scenari con ricadute disastrose sulla salute umana, sugli ecosistemi locali, sugli habitat di popolazioni animali e vegetali, sulle loro migrazioni forzate e sulla capacità adattativa: situazioni complesse di inquinamento e distruzione che possono riverberarsi in modi anche inaspettati e non prontamente evidenti.
L’ambiente nella sua complessità e nella sua ricchezza è nel mezzo.
Sconvolto molto spesso in quelle che sono le sue strutture elementari che consentono la vita.
Ecosistemi resi inospitali da chi si pone l’obiettivo destabilizzante di traumatizzare le società e governarle con il terrore.
E abusa dell’ambiente.
Sin dalla dichiarazione di San Pietroburgo nel 1899 si è stabilito che “la scelta del mezzo di guerra non è illimitata”: tale affermazione fu ribadita anche con la Convenzione de L’Aia e statuita definitivamente con la risoluzione ONU 31/72 del dicembre 1976 che diede forma e sostanza alla Convenzione ENMOD “Convention on the Prohibition of Military or any other hostile use of environmental modification techniques”.
La guerra non è un campo aperto e infinito – dice la comunità internazionale – ma deve rispettare alcune regole d’ingaggio. Tra le quali anche il divieto di modificazione dell’ambiente.
Ma cosa succede quando il confronto avviene con gruppi armati non riconosciuti istituzionalmente(NSAG)? Cosa succede se il nemico è subdolamente nascosto e agisce senza alcuno scrupolo?
Questa è la minaccia asimmetrica dove l’unica regola è “Non ci sono regole” e ogni mezzo è preso in considerazione, compresi quelli in danno all’ambiente.
Danneggiamento degli acquedotti, avvelenamento delle acque superficiali, distruzione delle colture agricole: a questo si aggiunge la predazione incontrollata di specie animali e vegetali, richiesti nel mercato illegale (avorio, corno di rinoceronte, pappagalli, serpenti, legname pregiato) che diventano fonte di finanziamento per i terroristi.
A fronte dell’attenzione maggiore che i temi e le problematiche ambientali hanno guadagnato anche nei contesti internazionali ci si trova ancora a prendere atto che l’ambiente viene minacciato dal terrorismo e, in misura non molto inferiore, anche dalle attività che lottano contro il terrorismo.
E l’ambiente si trova tra fuochi incrociati, cadendo spesso vittima di fuoco amico.
Da una parte la sproporzione di chi non ha remore ad attentare alla salute umana e agli ecosistemi e dall’altra chi si trova costretto a scendere nella stessa arena per arginare questo fenomeno pericoloso e destabilizzante.
E’ questa una delle tematiche di maggiore rilievo ed attualità: la mitigazione degli effetti sull’ambiente dovuti alle azioni antiterrorismo. E’ necessario infatti che ci sia la precisa coscienza, dal punto di vista strategico, che il contrasto non può avvenire incondizionatamente e a qualunque costo ambientale ma debba salvaguardare ambiente e natura che sono tra i presupposti fondamentali per il superamento di conflitto o post-conflitto.


 “Ad un primo esame esterno si esclude che l’animale sia stato ucciso da un’arma da fuoco”, “Il corpo non presentava segni di traumi”, “Sicuramente investito”… ma siamo sicuri?
“Ad un primo esame esterno si esclude che l’animale sia stato ucciso da un’arma da fuoco”, “Il corpo non presentava segni di traumi”, “Sicuramente investito”… ma siamo sicuri?



 Generale Isidoro Furlan, 46 anni di attività lavorativa tutta impostata nel rispetto della natura prima nel Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali, per tutelare l’ambiente.
Generale Isidoro Furlan, 46 anni di attività lavorativa tutta impostata nel rispetto della natura prima nel Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali, per tutelare l’ambiente. Sei un ecologo che ha fatto anche varie esperienze di politica universitaria, come quella di Direttore di Dipartimento, di Preside e di Magnifico Rettore. Per cui dovresti essere la persona più adatta a spiegarci la funzione dell’Università nella crescita culturale di una società, nel trasferimento delle conoscenze e, in particolare, nell’educazione al pensiero scientifico.
Sei un ecologo che ha fatto anche varie esperienze di politica universitaria, come quella di Direttore di Dipartimento, di Preside e di Magnifico Rettore. Per cui dovresti essere la persona più adatta a spiegarci la funzione dell’Università nella crescita culturale di una società, nel trasferimento delle conoscenze e, in particolare, nell’educazione al pensiero scientifico. Sei identificato come il “segretario storico della Lipu”, quello che, assieme ad altri amici, ha contribuito a fondare e a sviluppare un’importante coscienza ambientalista nel nostro paese. Parallelamente, grazie al tuo lavoro pionieristico, hai fatto capire che l’ambientalismo ha un senso pieno quando viene seguito da azioni concrete, e l’hai ampiamente dimostrato inaugurando il “primo ospedale per rapaci” italiani, attività coraggiosa e all’epoca estremamente innovativa. Cosa trovi di altrettanto coraggioso ed innovativo nell’attuale panorama ambientalista italiano e cosa andrebbe fatto?
Sei identificato come il “segretario storico della Lipu”, quello che, assieme ad altri amici, ha contribuito a fondare e a sviluppare un’importante coscienza ambientalista nel nostro paese. Parallelamente, grazie al tuo lavoro pionieristico, hai fatto capire che l’ambientalismo ha un senso pieno quando viene seguito da azioni concrete, e l’hai ampiamente dimostrato inaugurando il “primo ospedale per rapaci” italiani, attività coraggiosa e all’epoca estremamente innovativa. Cosa trovi di altrettanto coraggioso ed innovativo nell’attuale panorama ambientalista italiano e cosa andrebbe fatto? La tua vita lavorativa coincide con la storia dei parchi italiani. Ti sei scelto un mestiere difficile, molto spesso, dai più, poco compreso. Essere direttore di un’area protetta significa elaborare tattiche e strategie tipiche della biologia della conservazione e lavorare affinché questi stessi principi vengano metabolizzati dai non addetti ai lavori e dal pubblico che quelle aree protette le visita e, a diverso titolo, ne fruisce. Quanto è difficile, seppur gratificante, il lavoro del direttore di un’area protetta in Italia?
La tua vita lavorativa coincide con la storia dei parchi italiani. Ti sei scelto un mestiere difficile, molto spesso, dai più, poco compreso. Essere direttore di un’area protetta significa elaborare tattiche e strategie tipiche della biologia della conservazione e lavorare affinché questi stessi principi vengano metabolizzati dai non addetti ai lavori e dal pubblico che quelle aree protette le visita e, a diverso titolo, ne fruisce. Quanto è difficile, seppur gratificante, il lavoro del direttore di un’area protetta in Italia? Da un’esperienza più che trentennale di giornalismo e di comunicazione scientifica (ricordo anche l’importante lavoro che ha svolto al Ministero dell’Università e della Ricerca) come giudica la costante avversione e sospetto che la scienza suscita in Italia?
Da un’esperienza più che trentennale di giornalismo e di comunicazione scientifica (ricordo anche l’importante lavoro che ha svolto al Ministero dell’Università e della Ricerca) come giudica la costante avversione e sospetto che la scienza suscita in Italia? I recenti risultati delle elezioni europee ci hanno descritto una vera e propria “ondata verde” in quasi tutto il continente a parte l’Italia dove, in assoluta controtendenza, Europa Verde riesce ad ottenere un consenso del 2.4%. L’Europa della solidarietà e un impegno concreto contro la crisi climatica sono stati metabolizzati da molti europei, ma non dagli italiani. Se e cosa non ha funzionato?
I recenti risultati delle elezioni europee ci hanno descritto una vera e propria “ondata verde” in quasi tutto il continente a parte l’Italia dove, in assoluta controtendenza, Europa Verde riesce ad ottenere un consenso del 2.4%. L’Europa della solidarietà e un impegno concreto contro la crisi climatica sono stati metabolizzati da molti europei, ma non dagli italiani. Se e cosa non ha funzionato?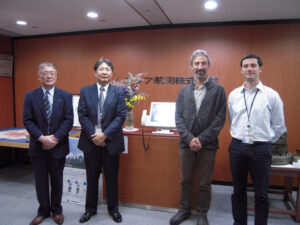 Penso di non andare molto lontano se provo a immaginare la tua mappa mentale come una rappresentazione del pensiero in cui ci sono due componenti principali: una solita e rigorosa base naturalistica e un altrettanto rilevante componente informatica. Quali delle due sono state determinanti, se lo sono state, per la gestione dei conflitti che hai incontrato fino ad ora nel tuo lavoro?
Penso di non andare molto lontano se provo a immaginare la tua mappa mentale come una rappresentazione del pensiero in cui ci sono due componenti principali: una solita e rigorosa base naturalistica e un altrettanto rilevante componente informatica. Quali delle due sono state determinanti, se lo sono state, per la gestione dei conflitti che hai incontrato fino ad ora nel tuo lavoro?